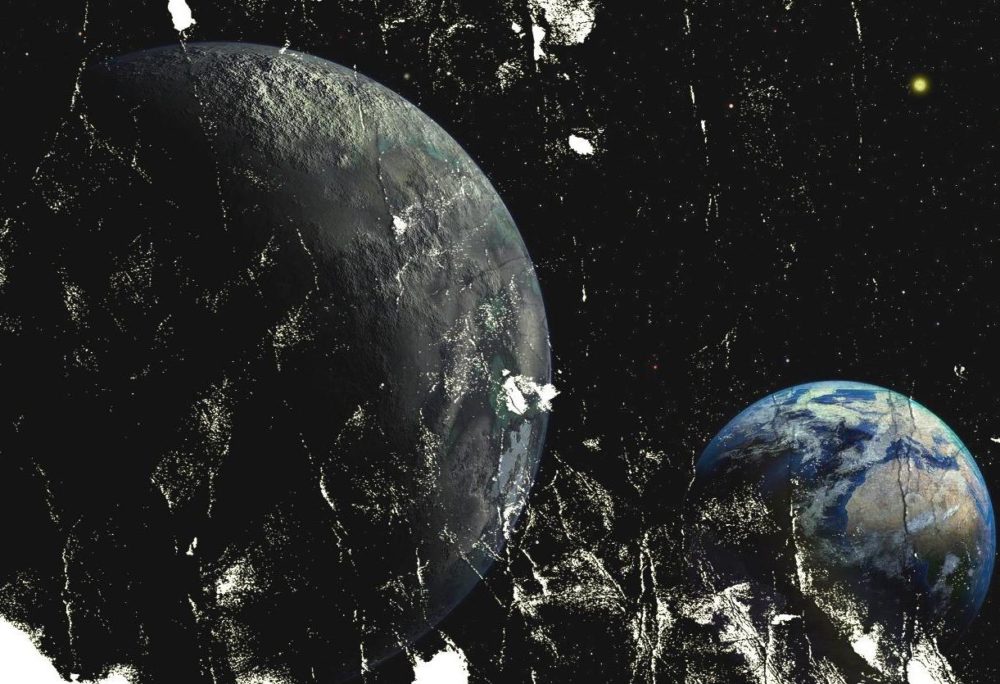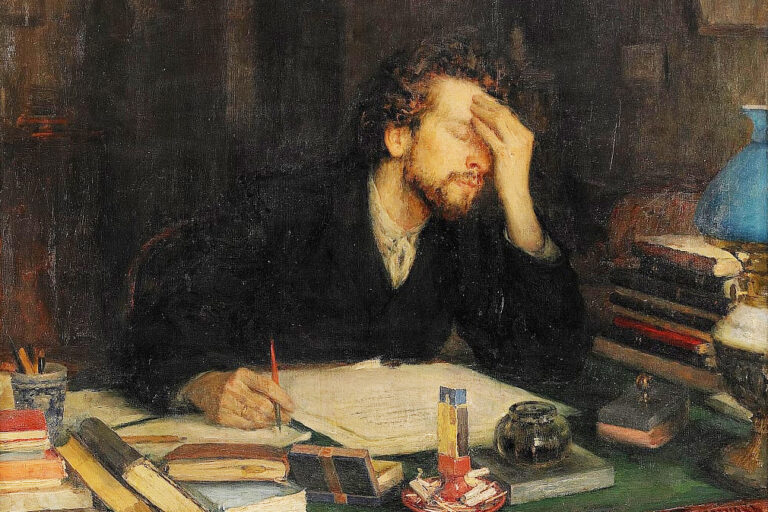Durante l’estate dei miei quindici anni incontrai una creatura proveniente da un altro sistema solare.
Non me ne accorsi immediatamente. A quel tempo ero convinto che, terrestri a parte, nell’universo non esistessero altre forme di vita.
Successivamente conobbi una teoria che sostiene l’esistenza di una stella, parallela al sole, attorno alla quale ruoterebbe un’altra serie di pianeti.
Di questi, il più esterno, si spingerebbe fin dalle parti di Nettuno. Proponendosi come decimo pianeta. O pianeta “X”.
La presenza di “X” all’interno del nostro sistema solare ne muterebbe il campo gravitazionale, inducendo creature extraterrestri a manifestarsi.
Si tratta di informazioni che allora non conoscevo.
Inoltre pensavo che, nel caso fossero giunti sulla terra, gli alieni sarebbero stati riconoscibili per la lingua incomprensibile, il colorito verdastro della pelle e per la forma inconsueta delle orecchie o degli occhi.
Lei, invece, di speciale aveva i piedi.
Sembravano normalissimi piedi di adolescente, ma non era così.
Su di me esercitavano un’attrazione magnetica: non riuscivo a smettere di guardarli. Li esaminavo procedere sicuri sulle pietre grosse della spiaggia; mentre Il rosso lucente sulle sue unghie risplendeva, lei ancheggiava senza mai smarrire l’equilibrio.
Quei piedi le conferivano la sicurezza e il portamento di una piccola donna. Anche sull’arena rovente, lei andava senza sforzo.
Erano piedi di una bellezza stupefacente che lasciavano sulla sabbia umida impronte perfette che il mare, per quanto si sforzasse, non riusciva a cancellare.
A volte immaginavo che, da un momento all’altro, lei potesse cambiare direzione ed iniziare a camminare sulle onde. Come Gesù.
Fu, credo, per un imprevedibile movimento cosmico che quella spiaggia incrociò la sua orbita.
Un transito che lei mimetizzò perfettamente, tanto che alla fine di Agosto la sua partenza sembrò identica a quella di tutti gli altri visitatori.
Piuttosto, non era previsto che a Settembre ricevessi una sua lettera.
Era una busta rettangolare e stretta. Bianca, col bordo superiore colorato di rosa. Non avevo mai ricevuto una lettera: leggere il mio nome sul frontespizio mi parve strano. Rilessi più volte il nome del mittente. Il suo stampatello era aggraziato e deciso. Nell’angolo in alto a destra, il francobollo raffigurava il duomo della sua città.
Perché aveva deciso di scrivermi? Cosa la spingeva a stabilire quel contatto?.
Riflettendoci non era nemmeno possibile che ciò avvenisse.
Quando tagliandola lungo il bordo rosa, apri la busta, mi accorsi che annunciava avvenimenti di un mondo lontano: la metropolitana, un grande liceo, il cinema multisala, le code ai grandi magazzini, la domenica al lago.
Fu così che ripensai ai suoi piedi: “C’erano pietre sulle rive del lago? Se si, erano diverse da quelle del mare? Era in grado di camminarci sopra ?”.
Ma erano altre immagini a turbarmi.
Immaginavo i suoi piedi sigillati in scomode scarpe, spostarsi su marciapiedi affollati, attraversare strade intasate d’auto e agitarsi in piscina; oppure immobili a teatro, stretti su un treno, in fila alla cassa del supermercato, sotto il tavolo di un ristorante cinese.
Mi sembrarono immagini violente: per me i suoi piedi dovevano restare nudi per muoversi liberi davanti al mare. Tutte le altre erano versioni generate da variabili indecifrabili.
Giungendomi dallo spazio, avrei dovuto mettere quella lettera in una teca e conservarla come si custodiscono i frammenti di roccia provenienti da Marte.
Viceversa, osai risponderle.
Non è più il tempo per stabilire di chi fu la responsabilità; chi commise l’imprudenza di generare quegli scritti che andavano e venivano.
Non si faceva in tempo a replicare ad una lettera, che già si attendeva che ne arrivasse un’altra; e, un minuto dopo averla letta, già si era impegnati a scriverne una nuova.
Quel traffico occupò il nostro autunno; neppure l’inverno lo interruppe. Quella comunicazione tra i confini del mondo conosciuto, era una spettacolare conquista.
Ma la tecnologia, già allora, disponeva di uno strumento sufficientemente collaudato per accorciare ulteriormente quegli spazi immensi: il telefono.
La prima telefonata fu preceduta da una lenta procedura, fatta di addestramenti, esercizi e simulazioni.
Preparativi che adesso sarebbero sbrigati in pochi minuti, impiegarono settimane per esaurirsi.
Finché, la domenica pomeriggio, a turno, iniziammo a chiamarci.
Il cambio di cerimoniale spostò tutti gli equilibri: ogni singolo viaggio durava un tempo infinitamente breve e, ogni volta, per atterrare su quel pianeta, effettuavo scrupolose manovre preliminari.
Se ero io a dover chiamare, mi sinceravo di poter restare, per il tempo necessario, solo in camera.
Là ripassavo a memoria le cose che desideravo dire. A volte mi scrivevo le frasi per evitare che l’emozione le rimuovesse.
Per connettermi, schiacciavo lentamente i pulsanti sulla plancia di comando del mio trasmettitore.
Se era lei a dover chiamare, trascorrevo la maggior parte del tempo a controllare la linea. Posizionavo la suoneria sul volume al massimo e, furtivo, sollevavo il ricevitore implorando il “tuu… tuu” del segnale libero.
Lo squillo del telefono suonava come l’allarme di una gioielleria; di più! Come la sirena per un imminente incursione aerea.
Entrambi ci annunciavamo con lo stesso ritornello: “Pronto casa… ?, per favore c’é… ?.”.
Si trattava di una formula del tutto superflua.
Non ci servivano conferme: ci riconoscevamo dal respiro.
Stabilito il contatto, dai nostri rispettivi sistemi solari, ci spedivamo messaggi senza logica, articolando quesiti puramente formali.
“Com’è andata a scuola ?”.
“Hai più visto quella tua amica?”.
“Cosa fai questa settimana?”.
“Ti piace quella canzone?”.
“E quel programma in televisione?”.
“Hai una sorella? Davvero! Sai che non lo sapevo?”.
Trasmissioni in codice tra due creature, incrociatesi solamente a causa di eccezionali traiettorie planetarie.
A volte ero tentato di chiederle dei suoi piedi.
“Sono sempre così belli?”
“Cammini mai a piedi nudi per casa?”.
“Non avrai mica cambiato il colore dello smalto?”
Ma sarebbero stati eccezionali sforamenti al copione; quelle conversazioni dovevano rimanere puri esercizi di retorica.
Ma non fu così.
Una domenica mi disse.
“Sai, forse torno”.
“Torni?”.
“Non è ancora sicuro!”.
“Ma quando?”.
“Tra due settimane”.
Mi sembrò di vederla, nella sua camera, seduta sul letto con i suoi piccoli piedi alieni incrociati, che giocava col filo del telefono, mentre lo diceva.
Immaginai l’onda d’urto di quelle parole scontrarsi sulle pareti della sua navicella spaziale fino a farla vibrare.
“Ma non è ancora sicuro!”.
Troppo tardi: il segnale radio, veloce com’è veloce il suono, era già a destinazione.
“Dai. Se vengo ci vediamo!” confermò.
E così, da quel momento, nessun altro giorno ebbe più significato. Quel tempo in mezzo imboccò un tunnel che si dirigeva precisamente verso il momento in cui l’avrei rivista. Nel frattempo la mia fantasia elaborò infinite situazioni, come accade a chiunque frequenti ancora l’asilo dei sentimenti.
Il giorno del suo ritorno, alle cinque del pomeriggio, poggiato alla ringhiera del molo, spalle al mare, fissavo i tavolini nella piazza. Sapevo che lei sarebbe passata da là, come se qualcuno avesse tracciato al suolo un enorme ics per indicare l’atterraggio del suo disco volante.
Le condizioni erano ideali: l’odore di primavera era così forte che quasi infastidiva.
Per primi vidi i suoi piedi spuntare da dietro la tenda di una caffetteria e riconobbi il passo.
“Ciao” disse, quando fu ad un metro da me.
“Ciao” risposi, pensando che al telefono fosse più semplice.
“Eh, niente. Sono venuta!”.
“Sei venuta, si”.
Improvvisamente la primavera era sparita: un freddo artico era calato sul molo.
Era forse quella la temperatura del pianeta “X”?.
Le fissai i piedi. Erano sempre gli stessi che ricordavo camminare agilmente sulle pietre grosse.
Mi accorsi in quel momento che non era solamente una questione di piedi: il suo accento era differente, la pelle scintillava olivastra e il taglio degli occhi mi pareva stranamente allungato. Persino le orecchie erano di un ovale troppo preciso. Era, senza dubbio, troppo bella e differente: non poteva che appartenere ad un altro sistema solare.
Improvvisamente ebbi anche la sensazione che quell’incontro stesse avvenendo in anticipo di alcuni anni luce.
In astronomia occorre pazienza: per assistere al ritorno di una cometa o di un pianeta nello stesso punto, deve trascorrere quello chiamato “Periodo di rivoluzione”: la terra compie il suo giro in un anno, Giove impiega quasi 12 anni, Plutone 248.
Quant’è il periodo di rivoluzione del pianeta “X”? Nessuno lo sa.
Per questo avrei potuto dirle: “Scusa ma secondo i miei calcoli dovevamo rivederci tra circa trecento anni. Tuttavia, nel frattempo, possiamo continuare a telefonarci, a turno, ogni domenica”.
In effetti sarebbe stata una frase sconclusionata, ma se lei avesse rispettato gli intervalli astronomici, io avrei avuto almeno il tempo di togliere l’apparecchio ai denti, crescere di dieci centimetri, leggere “Tokyo blues” e “Anna Karenina”, vedere tutto il cinema di Scola e “C’era una volta in America”, prendere treni e aerei, visitare posti distanti, dare esami all’università, dormire in ospedale…
Avrei anche potuto studiare l’astronomia per sapere tutto quello che c’era da sapere del suo pianeta d’origine.
Così avrei avuto parole sufficienti per fare quello che invece fece lei: riempire quel vuoto.
“Sto con mia sorella. Mi aspetta laggiù” disse.
“Laggiù?”
Mi indicò un punto indefinito verso la piazza.
Non c’era nessuna sorella, o almeno io non la vidi. C’era solo uno spazio siderale, tetro come un buco nero.
“Ci vediamo in giro”.
Che vuol dire in giro? Quale giro? Dove? Pensai.
“Allora vado” disse.
E si voltò. I suoi piedi si allontanarono, più rapidi di come erano venuti. Lungo la via non c’erano massi grossi, il terreno era liscio e senza ostacoli, come una lunga pista di decollo.
Se fossimo appartenuti a due specie simili, riconoscendomi, avrebbe accelerato fino a correre ad abbracciarmi. Invece quello era stato un incontro ravvicinato di un orribile tipo: creature ineguali che venivano a contatto per un nuovo imprevisto errore di percorso dei rispettivi pianeti di appartenenza.
Oggi molti scienziati sono concordi nell’affermare che quello del pianeta “X” sia un falso problema. Che sia pressoché inutile cimentarsi nella ricerca di pianeti e forme di vita estranee al nostro sistema solare. Imprese di questo tipo sono svantaggiose dal punto di vista economico, incerte per benefici e dalle conseguenze pericolose.
“Se gli alieni ne fossero capaci” sostengono “avrebbero già visitato la terra. Se non l’hanno fatto è semplicemente perché non è necessario che ciò avvenga”.
Tuttavia nessuno scienziato vide ciò che accadde quel giorno.
Quando fu a ridosso della piazza vidi i suoi piedi sollevarsi dal terreno, prima di alcuni centimetri poi sempre più chiaramente. Per alcuni secondi la vidi allontanarsi camminando sospesa nel vuoto.
Fu un quel momento che afferrai tutto il coraggio che avevo e la rincorsi.
Correndo a perdifiato, scavalcai la statale fiondandomi sulla piazza, quindi voltai l’angolo della caffetteria imboccando il vicolo sulla destra. Quando fui là, scrutai fino in fondo alla via ma non la vidi. Allora corsi ancora fino all’incrocio e da là, seguii il viale alberato da dove, mi ricordavo, scendeva per il mare. Ma di lei non c’era più nessuna traccia.
Arrivai fin sotto la sua casa: le imposte erano sbarrate e il cancello pareva non venisse aperto da mesi.
Dopo quel pomeriggio, dal pianeta “X” non mi giunsero più né lettere, né telefonate.
A volte, in spiaggia, ancora attendo che quel periodo di rivoluzione termini.
Nel frattempo osservo altri piedi camminare sulla sabbia umida, lasciando impronte che il mare immediatamente rimuove.
FOLLOW ME ON TWITTER: @chrideiuliis
Leggi anche: